Nei secoli successivi la Cattedrale non subì particolari rimaneggiamenti o modifiche sostanziali;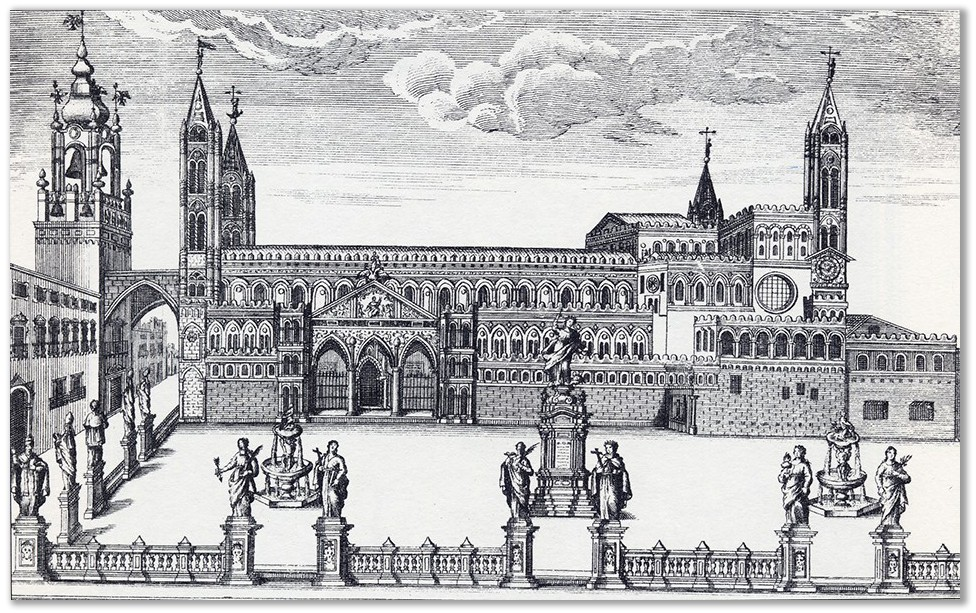 nel XIV secolo, fu completata la facciata occidentale e sopraelevate le 4 torri scalari vennero aggiunte le cappelle laterali e trasformati o ingranditi alcuni spazi liturgici.
nel XIV secolo, fu completata la facciata occidentale e sopraelevate le 4 torri scalari vennero aggiunte le cappelle laterali e trasformati o ingranditi alcuni spazi liturgici.
Nel XV e XVI secolo, la maggior parte degli interventi fu dedicata all’abbellimento dell’interno con la decorazione delle nuove cappelle e l’inserimento di opere scultoree di pregio. All’esterno fu affidata ad
Antonio Gambara
l’incarico di realizzare un nuovo portale e un
portico
sul fronte meridionale. Nella zona del Santuario fu affidato, nel 1509, ad
Antonello Gagini
il compito di realizzare l’imponente
tribuna marmorea
, che doveva abbellire l’intero catino dell’abside centrale, con risvolti decorati che si affacciavano sull’Antititulo.
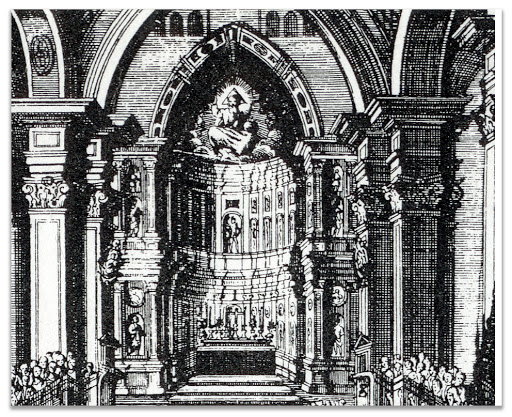 Nello stesso periodo venne ampliata l’area della sacrestia, con un nuovo corpo aggiunto, verso est.
Nello stesso periodo venne ampliata l’area della sacrestia, con un nuovo corpo aggiunto, verso est.
Dopo centinaia di anni l’edificio sacro, ancorché abbellito e curato dalla
Maramma
della Cattedrale, presentava i segni del tempo, in special modo per guasti strutturali alla fabbrica.
Alla fine del XVIII, l’occasione di tali lavori favorì l’avvio di un programma generale di ristrutturazione, trasformando profondamente la Cattedrale, secondo il gusto neoclassico dell’epoca, che ne determinò l’attuale assetto compositivo.
Il progetto fu affidato al regio architetto
Ferdinando Fuga
, ma la sua esecuzione operativa venne seguita dagli architetti palermitani
Carlo Chenchi
e
Giuseppe Venanzio Marvuglia
.
La Cattedrale venne, così, profondamente trasformata, al suo interno, come
una chiesa a croce latina
con la creazione del grande
transetto
con al centro una grande cupola, che ne connota, oggi, pesantemente la sagoma esterna. La trasformazione più evidente riguardò l’area presbiterale, dove fu abolito l’originale
Titulo
ed
Antititulo
della basilica normanna, con la realizzazione delle
cappelle del Santissimo Sacramento
e di
Santa Rosalia
,

il maggiore prolungamento del
cappellone del coro
, fino all’
abside maggiore
, scomposero la spazialità originaria della zona dell’Antititulo.
